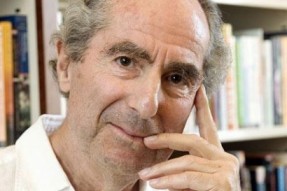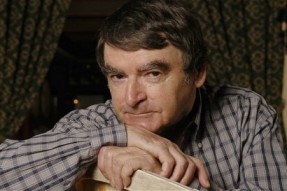Le tragicomiche avventure di Timofey Pnin
Vladimir Nabokov, Pnin, Garden City, N. Y., Doubleday 1957 (tr. it. Pnin, Mondadori, Milano 1967)

Due domande farebbe bene a porsi in via preliminare il lettore di un qualsiasi scritto in prosa o in versi di Nabokov: la prima è legata al genere del testo in esame, la seconda alle trappole autobiografiche — ovvero: di biografia literaria — che vi sono annidate. Il rischio di imbarcarsi in una lettura che ignori il caveat di cui sopra è quello di perdersi senza rimedio nei meandri di una fabulazione beffarda, elusiva, in ultima analisi fuorviante. Oggi, forse, non sarebbe possibile scambiare Lolita per un romanzo pornografico, e nemmeno sovrapporre alla figura di Humbert Humbert — intellettuale émigré che affida a un diario la sua ipnotica narrativa in prima persona — quella dell’autore reale. E tuttavia la tentazione di ridurre Pnin al romanzo del commiato alla carriera universitaria negli Stati Uniti è grande, se non altro per la graffiante ironia con la quale vi è dipinta, dall’interno, l’accademia americana degli anni cinquanta.
Fra il ’40 e il ’58, infatti, Nabokov insegna a Stanford, Cornell, e Wellesley — il Waindell College di Pnin. Come il protagonista del romanzo, lo scrittore sfuggito alla Germania nazista a un ventennio esatto dall’addio alla Russia rivoluzionaria accetta incarichi precari e mal pagati fra il New England e la California. Come il colto e sensibile Timofey Pnin, insomma, anche Vladimir Nabokov è costretto a improvvisarsi insegnante di lingua — e, naturalmente, di letterature comparate — in un panorama dove all’approccio semplicistico ma efficace dei parlanti nativi (“quelle stupende signore russe che si trovavano un po’ dovunque nell’accademia americana, le quali, senza alcuna formazione professionale, per intuito, loquacità, e una sorta di energia tutta materna, in qualche modo e come per magia riuscivano a infondere a un gruppo di studenti dallo sguardo ingenuo la conoscenza della loro lingua bella e difficile, in un’atmosfera fatta di canzoni sulla Grande Madre Volga, caviale rosso, e tè”), fa da contraltare il sapere iniziatico dei linguisti, sacerdoti di “quella consorteria ascetica di fonemi, quel tempio dove a giovanotti diligenti si insegna non la lingua in sé, ma il metodo per insegnare ad altri lo stesso metodo”.
Ma ecco come appare, nella finzione, quell’“istituto alquanto provinciale” che nell’improbabile pronuncia di Pnin è il Vandal College: il laghetto artificiale al centro del campus, il dozzinale busto di Venere, decorato in apertura di trimestre “con un finto bacio applicato col rossetto”, i ritratti murali degli insegnanti, immortalati “nell’atto di passarsi la torcia del sapere da Aristotele, Shakespeare e Pasteur”; e poi, ancora, l’ennesimo numero del bollettino d’ateneo sul Problema dei Parcheggi Riservati ai Docenti… e, ovviamente, i docenti. Impegnati, nella loro affannosa rincorsa ai titoli e alla carriera, a recensire i volumi dei colleghi più prolifici, a tramare nell’ombra contro i loro mentori, o a brigare per ottenere finanziamenti da favola “allo scopo di studiare le abitudini alimentari dei cubani” o di approntare “bibliografie di opere edite e inedite dedicate negli ultimi anni a un esame critico delle influenze dei seguaci di Nietzsche sul pensiero moderno”, vantano nomi fantastici (come la Dottoressa Rosetta Stone, vale a dire “Stele di Rosetta”, o il povero Professor Poore) e non si peritano di fare professione di ignoranza; come il Direttore del dipartimento di Lingua e letteratura francese, l’incomparabile Leonard Blorenge, nemico giurato di Pnin che “detestava la letteratura, e non sapeva una sola parola di francese”.
Di là dalla cornice a tratti grottesca nella quale si iscrive la storia, è possibile indovinare qua e là particolari di prima mano e perfino — ma è proprio il caso di stupirsi? — un certo numero di personaggi reali. E se il presidente di un College femminile, Frank Reade, compare nel ruolo di sé stesso in un raro quanto affettuoso omaggio a un uomo che lo scrittore trovava affascinante, nella figura di Blorenge è presa di mira la bête noire di Nabokov a Cornell, Gordon Fairbank, un associato di lingua niente affatto turbato dalla circostanza, da egli ammessa candidamente, di studiare il russo a mano a mano che lo insegnava ai suoi allievi; in modo analogo, la silhouette (vera) del direttore del Dipartimento di russo a Harvard, Samuel Hazzard Cross, si staglia dietro quella (fittizia) dell’anonimo “direttore del Dipartimento di lingue slave presso una Università molto più importante di Waindell, un venerabile impostore il cui russo era una barzelletta” che “aveva generosamente concesso di firmare”, ma non, ovviamente, di compilare, il volume degli assurdi esercizi di grammatica usato in classe da Pnin.
Il romanzo sarebbe dunque, dopotutto, un campus novel a sfondo autobiografico? A fugare ogni dubbio, ancorché ingenuo, sulla sua vera natura, interviene nell’ultimo capitolo il narratore — V. N., doppio autoriale e a un tempo personaggio fra i personaggi e funzione del testo —, col duplice ruolo di contribuire alla rovina di Pnin e di rendere al contempo inattendibile l’intero edificio del racconto. A conclusione del party organizzato in vista della tenure che ormai crede a portata di mano, infatti, Pnin vede svanire l’illusione di sfuggire al destino da outsider dell’esule allorché si rende conto di aver perso il posto per colpa del perfido V. N.. Col suo chisciottesco antieroe in eterna guerra con gli oggetti, deriso dai colleghi per le gaffes, i modi impacciati e l’American English da immigrato, Pnin è insomma un’operetta morale che a partire dal caso particolare dell’etica professionale invita a meditazioni di ben altro respiro, come testimonia la frase pronunciata in un istante epifanico dal personaggio preferito di Nabokov: “La storia dell’uomo è la storia del dolore”; dove con dolore si traduce qui pain, il lucido e fin troppo serio gioco di parole sul nome del protagonista che svela la natura tragica dell’intera vicenda.